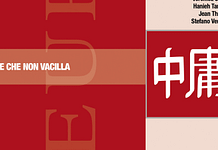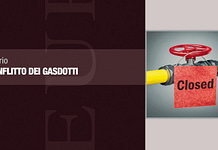Nella prima decade di maggio è avvenuto in Siria il più massiccio attacco aereo dal 1974, quando la Repubblica araba e lo Stato ebraico raggiunsero un accordo “di disimpegno”. In una sola notte l’esercito israeliano ha colpito una cinquantina di postazioni iraniane in territorio siriano, dopo che le forze speciali dei pasdaran avevano lanciato venti razzi contro postazioni israeliane sulle Alture del Golan. Secondo una nota diffusa dal ministero degli Esteri di Damasco, le incursioni aeree sioniste dimostrano che l’aggressione è “entrata in una nuova fase”, con “l’ingresso diretto del nemico nel conflitto in corso, senza più doversi nascondere dietro gruppi terroristi”. Una indiretta conferma di quanto affermato dal governo siriano si ricava dalla simultanea dichiarazione di Benjamin Netanyahu: “Siamo nel pieno di una battaglia continua e la nostra politica è chiara: non permetteremo all’Iran di acquartierarsi in Siria. Siamo preparati ad ogni scenario”.
Pochi giorni dopo l’attacco aereo israeliano, il 14 maggio 2018, gli Stati Uniti d’America hanno trasferito la loro ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, riconoscendo così ufficialmente alla città santa lo statuto di capitale dell’entità sionista insediatasi in Palestina. La scelta di una data non casuale per il trasferimento della sede diplomatica accentua ulteriormente il carattere provocatorio dell’iniziativa: il 14 maggio di quest’anno ricorre infatti il settantesimo anniversario della Nakba (in arabo: “catastrofe”), termine con cui viene indicato l’esodo forzato di circa 700.000 Palestinesi dai territori aviti occupati dai sionisti.
Il passo compiuto dagli USA, con cui il presidente Donald Trump paga il debito contratto coi finanziatori ebrei della sua campagna elettorale[1] e coi suoi sostenitori neocons e “cristiano-sionisti”, ha introdotto un nuovo fattore di divisione fra i paesi europei. Infatti, mentre l’Unione Europea e la stragrande maggioranza degli Stati membri, sfavorevoli all’iniziativa di Washington, hanno ritenuto opportuno di non accogliere l’invito a presenziare all’inaugurazione della nuova ambasciata, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria e Romania hanno invece inviato i loro rappresentanti. La stessa cosa ha fatto l’Albania, paese candidato all’ingresso nell’Unione, nonché altri due Stati che vorrebbero esservi ammessi, benché siano stati respinti a più riprese: Ucraina e Georgia.
Mentre all’ambasciata americana si festeggiava l’evento, il regime d’occupazione sionista massacrava i Palestinesi che si avvicinavano alla recinzione della loro prigione a cielo aperto; il ministero della Sanità di Gaza ha contato 58 morti ed oltre 2.700 feriti. Il presidente palestinese Abu Mazen proclamava uno sciopero per il giorno successivo e tre giorni di lutto, mentre l’ufficio del ministro sionista della Difesa Avigdor Lieberman impartiva l’ordine di “continuare ad agire con determinazione per prevenire qualsiasi attacco alla sovranità di Israele e ai cittadini israeliani” e un portavoce della Casa Bianca attribuiva a Hamas la responsabilità della strage. “Hamas voleva che i Palestinesi morissero”, ha insistito Netanyahu parlando a Londra nel mese di giugno.
Da quando era stato preannunciato lo spostamento dell’ambasciata, la tensione era aumentata sempre più e i venerdì della collera palestinese avevano visto morire decine e decine di persone. Per sette venerdì consecutivi i giovani di Gaza avevano partecipato alle manifestazioni chiamate “marce del ritorno”, fino all’anniversario della Nakba. Manifestazioni e interventi repressivi sono proseguiti nel mese di giugno.
Il più convinto sostegno alla causa palestinese è stato ribadito dalla Guida Suprema della Repubblica Islamica dell’Iran, in un discorso tenuto al termine del mese di Ramadan davanti ad un pubblico di alti funzionari e generali iraniani, nonché di ambasciatori di paesi musulmani. Dopo aver ricordato che “il regime sionista, fondato sulla menzogna, ha espulso una nazione storica dalla sua propria terra utilizzando la coercizione, le minacce e le azioni armate”, l’Ayatollah Khamenei ha dichiarato che la tragedia del popolo palestinese avrà termine quando verrà eliminato il regime sionista, il quale, d’altronde, è destinato a non durare a lungo.
Una settimana prima del trasferimento dell’ambasciata, il presidente Donald Trump, accampando presunte e mai dimostrate violazioni iraniane del trattato internazionale siglato a Vienna nel luglio 2015, aveva annunciato il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare iraniano. A sua volta, il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha minacciato l’adozione di “sanzioni senza precedenti” che costringeranno la Repubblica Islamica dell’Iran a “lottare per la sopravvivenza della propria economia” ed ha elencato una lunga serie di condizioni capestro alle quali l’Iran dovrebbe sottostare, qualora eventualmente volesse stipulare un nuovo accordo.
Il presidente iraniano Hassan Rohani replicava immediatamente all’annuncio di Trump, accusando gli Stati Uniti di non rispettare mai la parola data e di aver preso una decisione che avrebbe messo a rischio gli accordi internazionali; dichiarava inoltre che l’Iran sarebbe rimasto fedele all’Accordo di Vienna ed annunciava di avere ordinato all’Agenzia atomica di tenersi pronta a riprendere l’arricchimento dell’uranio. Successivamente, a margine della conferenza dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai svoltasi in Cina il 9 giugno, il presidente iraniano ha dichiarato che l’uscita degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare “rende necessaria una discussione importante e seria tra Mosca e Teheran”.
Non c’è dubbio che con queste due iniziative – il trasferimento della loro ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme e il ritiro dall’Accordo di Vienna – gli Stati Uniti hanno gettato altro olio sul fuoco in una regione già incandescente, nella quale gli alleati di Washington sono già sostanzialmente impegnati contro l’Iran: Israele in Siria e l’Arabia Saudita in Yemen.
Oltre allo Stato ebraico ed alla petromonarchia wahhabita, Washington ha nella regione un altro alleato, per giunta membro della NATO, che oggi sembra meno disponibile a farsi strumento di iniziative americane. Parliamo della Turchia, che negli ultimi tempi ha migliorato le sue relazioni con l’Iran e con la Russia. Infatti, mentre l’Arabia Saudita ha accolto con entusiasmo l’uscita degli USA dall’Accordo di Vienna, il ministro degli Esteri di Ankara ha definito la decisione americana come “un passo infelice” e il portavoce della Presidenza turca ha affermato che la decisione di Washington potrebbe incrementare la conflittualità nel Vicino Oriente.
L’avvicinamento di Ankara a Teheran è cominciato, sia pure tra una serie di contraddizioni, dopo che il fallito colpo di Stato del 15 luglio 2016 ha indotto Erdogan a sospettare la complicità dell’alleato statunitense coi militari golpisti; è proseguito ad Astana il 20 dicembre dello stesso anno coi negoziati per la pace in Siria condotti da Russia, Iran e Turchia; è continuato il 4 aprile 2018 ad Ankara, dove Putin, Erdogan e Rohani si sono impegnati a cooperare per ottenere un definitivo cessate il fuoco in Siria.
Se la prospettiva di un “triangolo eurasiatico” russo-iraniano-turco deve ancora assumere una forma più definita, la collaborazione fra Mosca e Teheran sul campo siriano è invece una realtà operativa che inquieta i dirigenti sionisti, i quali, come appare evidente dal viaggio di Netanyahu a Mosca in occasione della giornata della Vittoria, vorrebbero sbilanciare a loro favore il ruolo di arbitro che Putin cerca di svolgere fra l’Iran ed Israele. Infatti non bisogna dimenticare che, se l’Iran è per la Russia un alleato prezioso, Israele non solo intrattiene importanti relazioni economiche con la Russia, ma circa un sesto della popolazione è costituito da russi di origine più o meno ebraica, tanto che Putin ha potuto dichiarare: “Israele è per noi un Paese speciale. È praticamente un Paese russofono”[2].
Certo, il consolidarsi del “triangolo eurasiatico” aggregherebbe intorno a sé anche altri paesi (Siria, Libano, Iraq, Yemen…) e segnerebbe il fallimento del progetto di balcanizzazione del Vicino Oriente. Forse è proprio per il timore che tale prospettiva si realizzi, che gli Stati Uniti e l’entità sionista stanno premendo sull’acceleratore per scatenare una nuova guerra.
NOTE
[1] Si veda alle pp. 121-122 di questo numero di “Eurasia” l’articolo di Gilles Munier, nel quale sono riferite le rivelazioni dell’ex analista della CIA Philip Giraldi.
[2] Giovanni Quer, Cultura, lingua e identità: gli ebrei “russi” in Israele sono il soft power di Putin http://www.lastampa.it
Questo articolo è coperto da ©Copyright, per cui ne è vietata la riproduzione parziale o integrale. Per maggiori informazioni sull'informativa in relazione al diritto d'autore del sito visita Questa pagina.