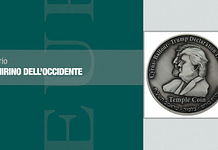Introduzione
L’operazione militare Carri di Gedeone II, avviata dall’esercito israeliano nel mese di agosto 2025, segna una svolta decisiva nel conflitto israelo-palestinese. Presentata come la fase finale per la “sconfitta di Hamas” e l’occupazione di Gaza City, essa appare in realtà come un progetto più ampio: ridefinire in maniera irreversibile la geografia politica e demografica della Striscia di Gaza.
Alla vigilia dell’operazione, il quadro era già in rapido deterioramento. Nelle settimane precedenti, Hamas aveva accettato una proposta di cessate il fuoco di sessanta giorni che includeva la liberazione di alcuni ostaggi e un incremento degli aiuti umanitari. Israele, però, non ha mai dato una risposta positiva: il governo Netanyahu ha continuato a porre condizioni massime – come la completa smilitarizzazione della Striscia – che di fatto hanno reso impossibile un’intesa.
In parallelo, il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato il richiamo di 60.000 riservisti, da affiancare ai 70.000 già in servizio, portando a circa 130.000 il totale delle truppe mobilitate. Un segnale chiaro che l’opzione militare era stata scelta come via principale, nonostante le critiche interne e le pressioni internazionali.
Nelle stesse ore, gli ordini di evacuazione sono stati estesi a interi quartieri di Gaza City, come Sheikh Ridwan e Jabalia, dove fino a quel momento si erano rifugiate migliaia di famiglie. Le immagini di donne e bambini costretti a lasciare scuole e ospedali trasformati in rifugi hanno testimoniato l’inizio di una deportazione di massa verso il sud della Striscia. La Croce Rossa e il Patriarcato Latino di Gerusalemme hanno denunciato che simili spostamenti, imposti a una popolazione già allo stremo, avrebbero aggravato una catastrofe umanitaria senza precedenti.
Contemporaneamente, il fronte politico israeliano è segnato da tensioni crescenti. Le famiglie degli ostaggi hanno bloccato le strade chiedendo un accordo immediato, mentre i ministri ultranazionalisti hanno minacciato la crisi di governo in caso di tregua. In questo contesto, Netanyahu ha scelto la via dell’escalation, ordinando di accelerare i tempi dell’assalto a Gaza City.
Mentre la popolazione civile viene spinta in massa verso il sud, in aree sempre più ristrette e prive di servizi, Tel Aviv punta a cancellare qualsiasi prospettiva di ricostruzione e di futuro politico palestinese. Questa scelta, che si accompagna alla contemporanea espansione delle colonie in Cisgiordania, avrà conseguenze profonde non solo per i rapporti tra israeliani e palestinesi, ma anche per gli equilibri interni di Israele e per l’intera regione mediorientale.
La logica dell’occupazione
Il piano operativo non mira soltanto a neutralizzare la capacità militare di Hamas. L’evacuazione forzata di oltre un milione di abitanti da Gaza City e la distruzione sistematica di case, scuole e ospedali rivelano un obiettivo più ampio: svuotare il cuore della Striscia, privare la popolazione della possibilità di tornare e trasformare il nord in un’area deserta sotto controllo militare permanente.
Dal punto di vista logistico, questo obiettivo si traduce in un uso combinato di bombardamenti aerei, demolizioni sistematiche e avanzate lente ma inesorabili delle truppe di terra. Ogni quartiere viene colpito dall’alto per aprire varchi, poi le unità corazzate avanzano accompagnate da squadre di fanteria e da bulldozer blindati che abbattono edifici, spianano strade e rendono l’ambiente inabitabile. La distruzione non è soltanto un effetto collaterale della guerra: è parte integrante della strategia, perché eliminando infrastrutture civili e luoghi di rifugio si impedisce agli abitanti di restare o di fare ritorno una volta terminata l’offensiva.
Parallelamente, la popolazione viene spinta verso sud attraverso corridoi controllati dall’esercito. Lì, tra al-Mawasi e i campi profughi già esistenti, dovrebbero trovare posto centinaia di migliaia di persone. In realtà queste aree non dispongono di risorse né di servizi minimi, e si trasformano rapidamente in zone di concentrazione dove la vita quotidiana è possibile solo grazie agli aiuti umanitari. La stessa logistica del trasferimento diventa uno strumento di controllo politico e militare, perché chi si sposta lo fa seguendo le direttive imposte dall’occupante e resta confinato in spazi ristretti e precari.
Questa logica è coerente con una politica israeliana di lungo periodo: creare fatti compiuti sul terreno che rendano impraticabile la nascita di uno Stato palestinese unitario e contiguo. Se a Gaza il meccanismo è quello della deportazione e della distruzione, in Cisgiordania si applica lo stesso principio attraverso l’espansione coloniale. La recente approvazione di oltre tremila nuove unità abitative nell’area E1, tra Gerusalemme e Ma’ale Adumim, spezza ulteriormente la continuità del territorio palestinese, divide le comunità in cantoni e consolida un sistema in cui ogni movimento dipende da corridoi e checkpoint che Israele può aprire o chiudere a piacimento.
In questo modo, Gaza e Cisgiordania diventano due laboratori dello stesso modello: la popolazione palestinese confinata in spazi limitati, sottoposta a un controllo costante e priva di qualsiasi prospettiva politica autonoma. Non si tratta quindi soltanto di una battaglia militare, ma di un ridisegno deliberato della geografia umana e politica del conflitto.
Hamas e la resistenza asimmetrica
Di fronte alla potenza di fuoco israeliana, Hamas non può reggere uno scontro convenzionale. L’Idf dispone di carri armati Merkava, blindati di ultima generazione, superiorità aerea e capacità tecnologiche avanzate. Il movimento palestinese, invece, ha scelto da tempo la strada della guerra irregolare, adattandosi al contesto urbano e sfruttando la conoscenza del territorio come arma principale.
Gli attacchi delle Brigate al-Qassam a Khan Younis e a Rafah, condotti con imboscate, ordigni esplosivi e missili anticarro, hanno dimostrato che, nonostante le devastazioni subite, Hamas mantiene una rete di combattenti in grado di colpire in maniera mirata. Piccoli gruppi si muovono attraverso tunnel sotterranei o passaggi nascosti tra le macerie, colpiscono colonne di mezzi corazzati e si ritirano prima che l’aviazione israeliana possa reagire. Questo metodo infligge perdite e rallenta l’avanzata dell’esercito, costringendolo a un dispendio enorme di tempo e risorse per ogni isolato conquistato.
La struttura logistica di Hamas è decentralizzata. Non dipende da un comando unico facilmente eliminabile, ma da cellule distribuite sul territorio, ognuna con margini di autonomia. I depositi di armi sono nascosti in zone residenziali o sotterranee, spesso collegati da gallerie. Questo rende difficile per Israele colpire in maniera definitiva i centri di comando e le riserve di armamenti. Anche dopo settimane di bombardamenti intensivi, Hamas riesce a lanciare razzi e a organizzare assalti mirati, segno di una capacità di adattamento radicata.
C’è poi un aspetto psicologico: per Hamas, non è necessario vincere sul piano militare. Basta resistere e continuare a colpire per dimostrare che Israele non riesce a sconfiggerlo. Ogni attacco riuscito, ogni convoglio colpito o soldato ferito alimenta una narrativa potente, quella della resistenza che sopravvive all’esercito considerato invincibile. Questo rafforza il consenso popolare a Gaza, dove la popolazione, pur allo stremo, vede in Hamas un attore che continua a opporsi all’occupazione. Allo stesso tempo, nel mondo arabo-musulmano, il movimento si accredita come simbolo di opposizione a Israele, ottenendo legittimità e sostegno morale.
La dinamica è paradossale. Quanto più Israele intensifica la pressione con bombardamenti e deportazioni, tanto più Hamas riesce a presentarsi come l’unica forza che continua a combattere, trasformando la sua stessa sopravvivenza in un successo politico. L’effetto finale è che, anche se ridotto nelle capacità militari, il movimento si rafforza sul piano politico e simbolico, rendendo più difficile per Israele dimostrare di aver raggiunto i propri obiettivi dichiarati.
La crisi interna israeliana
Sul fronte interno, l’operazione Carri di Gedeone II non appare come un momento di unità nazionale, ma come un catalizzatore delle contraddizioni che attraversano la società israeliana. Netanyahu ha trasformato la guerra in uno strumento di sopravvivenza politica: respinge sistematicamente ogni ipotesi di tregua, sostenendo che concedere una pausa nei combattimenti non farebbe altro che rafforzare Hamas e consentirgli di riorganizzarsi. In realtà, questa posizione permette al premier di mantenere una linea di intransigenza che risponde più alle esigenze del suo governo e della sua stessa permanenza al potere che a una valutazione strategica condivisa.
Le piazze israeliane, ormai da mesi, sono percorse da manifestazioni di massa. Le famiglie degli ostaggi chiedono un accordo immediato per riportare a casa i loro cari e accusano il governo di sacrificare le loro vite in nome della propaganda bellica. Accanto a loro, settori della società civile e dell’opposizione denunciano la guerra come priva di un obiettivo realistico, una spirale che logora lo Stato senza offrire soluzioni. Queste mobilitazioni non sono marginali: coinvolgono centinaia di migliaia di persone, paralizzano strade e snodi strategici, e mettono in discussione la narrazione ufficiale del governo.
La pressione si avverte anche dentro l’esercito. Molti riservisti, già richiamati più volte negli ultimi due anni, rifiutano di rispondere a nuovi ordini di mobilitazione. Denunciano condizioni insostenibili, turni prolungati al fronte e la mancanza di una prospettiva politica che dia senso ai sacrifici richiesti. La carenza stimata di circa 12.000 effettivi pesa enormemente sulla capacità dell’Idf di sostenere un’operazione lunga e complessa come quella di Gaza City.
Un ulteriore punto di tensione è rappresentato dal tentativo di integrare gli ultraortodossi. Finora esentati dal servizio militare, essi rifiutano in massa di arruolarsi, scendendo in strada per bloccare strade e incroci al grido di “non saremo carne da cannone”. La questione non è solo numerica ma simbolica: la guerra che avrebbe dovuto unire il Paese accentua invece la frattura tra gruppi sociali, religiosi e politici.
Di fronte a queste difficoltà, il governo ha lanciato campagne rivolte ai giovani della diaspora ebraica per spingerli a trasferirsi in Israele e arruolarsi. È un segnale della crisi di consenso e legittimità interna: lo Stato non riesce più a garantire l’adesione spontanea dei propri cittadini e cerca rinforzi all’esterno. Ma queste iniziative, pur se propagandisticamente rilevanti, non colmano la frattura che attraversa la società.
Il risultato complessivo è che la guerra, lungi dal rafforzare la coesione, accentua la divisione. Da un lato, una parte della popolazione continua a vedere nell’occupazione una necessità di sicurezza, convinta che solo la forza militare possa garantire l’esistenza stessa di Israele. Dall’altro, cresce il numero di cittadini che percepiscono l’operazione come un vicolo cieco, un conflitto senza fine che non solo non porta sicurezza, ma rischia di mettere in pericolo la tenuta della società israeliana stessa.
La dimensione internazionale
L’avvio dell’operazione è avvenuto in concomitanza con un fatto di grande rilievo politico: l’accettazione, da parte di Hamas, di una proposta di cessate il fuoco di sessanta giorni. Questa offerta, sostenuta da mediatori internazionali, prevedeva il rilascio di una parte degli ostaggi e l’ingresso massiccio di aiuti umanitari. Israele ha tuttavia scelto la strada dell’escalation, ponendo condizioni ritenute impraticabili, come la smilitarizzazione totale della Striscia, e compromettendo così ogni possibilità di apertura diplomatica. La comunità internazionale si è trovata di fronte a un bivio: appoggiare un cessate il fuoco realistico, pur parziale e imperfetto, oppure accettare – apertamente o con il silenzio – la prosecuzione di una guerra di logoramento.
Gli Stati Uniti restano l’attore esterno decisivo. Continuano a fornire copertura diplomatica a Israele presso le Nazioni Unite, bloccando le risoluzioni più critiche e garantendo forniture militari indispensabili per sostenere l’offensiva. Washington ha moltiplicato i richiami pubblici alla “protezione dei civili”, ma si tratta di pressioni più retoriche che sostanziali: non incidono sulla condotta israeliana, né sulla prosecuzione dei bombardamenti nelle aree residenziali e persino nei campi di evacuazione. L’Europa appare divisa e marginale, incapace di presentare una linea comune. Alcuni Stati, come Germania e Paesi Bassi, mantengono un forte allineamento con Israele; altri, come Spagna e Irlanda, spingono per un riconoscimento immediato dello Stato palestinese. Il risultato è una paralisi diplomatica che riduce il peso europeo a un ruolo secondario.
Il mondo arabo, a sua volta, non riesce a esprimere una posizione unitaria. Gli Stati che hanno avviato processi di normalizzazione con Israele, come Emirati Arabi Uniti e Bahrein, mantengono un silenzio prudente, consapevoli della fragilità dei propri equilibri interni. Altri Paesi, come Giordania e Qatar, denunciano invece il rischio di un collasso regionale: Amman teme un nuovo esodo verso i propri confini, Doha sottolinea l’impossibilità di gestire una crisi umanitaria di queste proporzioni senza un cessate il fuoco immediato. L’Egitto, che condivide con Gaza il confine di Rafah, si trova in una posizione delicata: da un lato, teme un’ondata di profughi che destabilizzerebbe il Sinai; dall’altro, non vuole apparire come il complice di una deportazione di massa.
Sul piano umanitario, la situazione è catastrofica. Più dell’80% della popolazione di Gaza è stato costretto a lasciare le proprie case e a rifugiarsi in aree sovraffollate prive di acqua, elettricità e servizi sanitari. Le infrastrutture civili sono ridotte in macerie: scuole, ospedali e centri di accoglienza sono stati bombardati o abbandonati. La malnutrizione colpisce ormai decine di migliaia di bambini, mentre le agenzie internazionali denunciano la diffusione di malattie infettive nei campi di fortuna. Neppure le aree di evacuazione dichiarate “sicure” da Israele offrono protezione: più volte sono state colpite da raid aerei o da colpi di artiglieria, dimostrando che, nella Striscia, nessun luogo è davvero al riparo.
La guerra di Gaza diventa così un banco di prova per la credibilità del sistema internazionale. Le potenze occidentali oscillano tra la difesa di Israele e l’imbarazzo per le conseguenze umanitarie, il mondo arabo si muove tra impotenza e denuncia, e le agenzie delle Nazioni Unite si trovano a gestire un disastro senza precedenti con margini di azione sempre più ristretti. Il risultato è una paralisi diplomatica che lascia sul campo una sola certezza: l’offensiva militare procede senza vincoli, mentre la popolazione civile paga il prezzo più alto.
Prospettive
Guardando al futuro immediato, Israele potrebbe riuscire a conquistare quartieri strategici di Gaza City e proclamare un successo militare. Tuttavia, il prezzo da pagare sarebbe enorme: ogni avanzata comporta perdite significative, richiede un impiego massiccio di mezzi e lascia dietro di sé soltanto macerie. Anche qualora l’Idf ottenesse il controllo formale della città, il mantenimento dell’occupazione imporrebbe la presenza permanente di migliaia di soldati, impegnati in operazioni di pattugliamento e in continue bonifiche. Sarebbe una gestione costosa e logorante, sia dal punto di vista economico che umano.
Dal lato palestinese, Hamas non verrebbe eliminato. La sua struttura decentrata e la capacità di operare in modo asimmetrico garantiscono la sopravvivenza del movimento, che continuerebbe a condurre imboscate, lanciare razzi e colpire con ordigni improvvisati. Anche se militarmente indebolito, riuscirebbe a trasformare la sua stessa resistenza in una vittoria politica, alimentando il consenso interno e proiettandosi come simbolo di opposizione in tutto il mondo arabo e musulmano. Questo significa che Israele si troverebbe di fronte non a una fine del conflitto, ma a una sua trasformazione in guerra di logoramento permanente.
Sul piano interno, le prospettive non sono meno critiche. Netanyahu appare legato mani e piedi agli alleati di governo più radicali, che respingono qualsiasi ipotesi di tregua. Ma la società israeliana è divisa: da un lato settori che vedono nella prosecuzione della guerra l’unica via per garantire sicurezza, dall’altro movimenti sempre più vasti che considerano l’occupazione un vicolo cieco. Se la guerra si prolunga, è plausibile un acuirsi della frattura politica interna, con ripercussioni anche sulla stabilità del governo e sulla coesione dell’esercito.
A livello regionale, l’operazione rischia di alimentare una spirale di destabilizzazione. Paesi confinanti come Giordania ed Egitto temono nuove ondate di profughi, mentre l’opinione pubblica nel mondo arabo spinge i governi a prendere posizioni più dure. Una prosecuzione del conflitto senza sbocchi potrebbe inoltre accentuare tensioni latenti in diversi Paesi vicini, già attraversati da fragilità economiche e politiche, e rendere più instabile l’intero assetto regionale. In questo scenario, Tel Aviv rischia di trovarsi intrappolata in un conflitto prolungato non solo a sud, ma anche sotto forma di crescenti pressioni e isolamento diplomatico lungo tutti i suoi confini.
Infine, la prospettiva più drammatica riguarda la popolazione civile di Gaza. Milioni di persone vivono ormai in condizioni di sovraffollamento, con scarse risorse alimentari e senza infrastrutture sanitarie. Ogni ulteriore mese di guerra aumenta il rischio di carestie ed epidemie, con conseguenze non solo umanitarie, ma anche politiche: il disastro potrebbe trasformarsi in un catalizzatore di nuove ondate di radicalizzazione.
In sintesi, le prospettive non preannunciano una conclusione del conflitto, ma la sua radicalizzazione. Israele potrebbe vantare un controllo territoriale temporaneo, ma a costo di logorarsi internamente e di rafforzare paradossalmente Hamas come simbolo di resistenza. La Striscia di Gaza rischia di diventare un territorio svuotato e frammentato, privo di futuro politico, mentre la regione mediorientale si trova esposta a un’ulteriore instabilità. Carri di Gedeone II, lungi dal chiudere la partita, apre una nuova fase di incertezza che potrebbe durare anni.
Questo articolo è coperto da ©Copyright, per cui ne è vietata la riproduzione parziale o integrale. Per maggiori informazioni sull'informativa in relazione al diritto d'autore del sito visita Questa pagina.