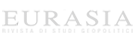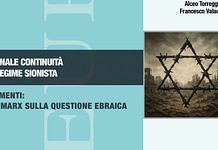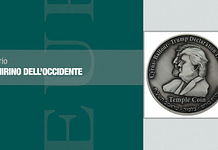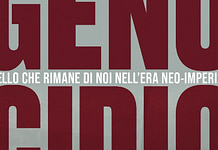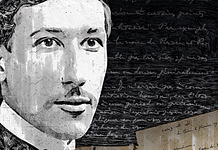Introduzione
Il testo di Roberto Giuliani, dal titolo Il focolare ebraico – National Home, si presenta come un contributo alla comprensione della “questione palestinese” attraverso un excursus storico sulla nascita di Israele e sulle sue conseguenze. Tuttavia, sin dalle prime righe emerge con chiarezza un’impostazione che privilegia in maniera netta la prospettiva ebraico-sionista, minimizzando o ignorando elementi fondamentali della narrazione e dell’esperienza palestinese.
Non si tratta soltanto di un problema di schieramento politico. Ogni ricostruzione storica implica scelte interpretative, ma ciò che colpisce nel testo di Giuliani è l’uso di semplificazioni, anacronismi e omissioni che finiscono per deformare il quadro complessivo. La storia della Palestina e di Israele è tra le più intricate e controverse del Novecento, e proprio per questo richiede rigore metodologico, equilibrio e la capacità di tenere insieme più voci, spesso tra loro conflittuali. Quando invece la narrazione si appiattisce su un’unica prospettiva, il rischio è duplice: da un lato si offre al lettore un racconto che può sembrare autorevole ma che risulta parziale, dall’altro si contribuisce a consolidare stereotipi che hanno avuto — e continuano ad avere — conseguenze politiche e umane drammatiche.
La questione palestinese non è una disputa astratta tra due narrazioni equivalenti: è la storia concreta di un popolo privato della propria terra, dei propri diritti e della possibilità di autodeterminarsi. Ignorare o marginalizzare questa dimensione significa svuotare il conflitto del suo cuore pulsante. Una lettura equilibrata dovrebbe tener conto di entrambe le dimensioni, senza cancellarne una a vantaggio dell’altra.
La replica che segue intende affrontare punto per punto le affermazioni di Giuliani, riportando i passaggi centrali del suo testo e mettendoli a confronto con le acquisizioni della ricerca storica e con una prospettiva che includa finalmente anche la voce palestinese, troppo spesso relegata ai margini. L’obiettivo non è sostituire una narrazione con un’altra, ma restituire complessità a una storia che non può essere compresa se non nella sua interezza, con tutte le sue contraddizioni e le sue ferite ancora aperte.
Le entità statuali prima dell’Antico Israele
Giuliani scrive: «fino all’arrivo degli ebrei in quelle terre non è mai esistita prima una qualche entità di tipo statuale indipendente».
Questa affermazione è problematica e riduttiva. La ricerca storica e archeologica mostra che la Palestina preisraelitica non era affatto un territorio privo di organizzazione politica. Già nell’Età del Bronzo antico (III-II millennio a.C.) esistevano città-stato fiorenti come Hazor, Megiddo, Lachish e Bet Shean, dotate di mura monumentali, sistemi di irrigazione, magazzini per lo stoccaggio, templi e palazzi reali. Hazor, ad esempio, era un importante centro politico ed economico che controllava le vie commerciali tra Egitto, Siria e Mesopotamia. Le lettere di Amarna (XIV secolo a.C.), corrispondenza diplomatica tra i faraoni egiziani e i re cananei, ci mostrano una rete intricata di città governate da sovrani locali, con relazioni di vassallaggio e alleanza, in grado di negoziare, guerreggiare e commerciare.
Quando gli israeliti si insediarono nelle alture della Palestina, attorno al XII-XI secolo a.C., non entrarono in un “vuoto di potere”, ma in una regione già strutturata, con culture complesse e centri urbani consolidati. I regni di Israele e Giuda stessi sorsero dentro questa realtà, ereditando forme amministrative e culturali dai cananei. Perfino il tempio di Salomone a Gerusalemme presenta forti influenze architettoniche fenicie.
Dire che non esistette nulla prima dell’arrivo degli ebrei significa dunque cancellare secoli di storia cananea, filistea, fenicia e aramea. La Palestina è sempre stata un crocevia di civiltà: gli egizi vi condussero campagne militari già nel II millennio a.C., i micenei vi portarono manufatti e tecnologie, i popoli del mare si insediarono lungo le coste, fondando città come Gaza e Ashkelon.
L’affermazione di Giuliani non è quindi solo imprecisa sul piano storico: ha anche un portato politico, perché riprende implicitamente la formula sionista della Palestina come “terra senza popolo per un popolo senza terra”. In realtà, quella terra è sempre stata abitata, popolata da comunità organizzate, in relazione con i grandi imperi circostanti, e mai riducibile a uno spazio vuoto in attesa dell’arrivo di Israele.
La diaspora e il “ritorno”
Giuliani afferma: «Ai Giudei non rimase che raccogliersi sulla meditazione delle leggi mosaiche e Israele non abbandonò la speranza di una restaurazione di Sion […] sognando il RITORNO».
Questa affermazione mescola dimensioni diverse e rischia di falsare la prospettiva storica. È vero che dopo la distruzione del Secondo Tempio (70 d.C.) e la rivolta di Bar Kokhba (132–135 d.C.) la vita ebraica si riorganizzò intorno alla Torah e alla tradizione rabbinica, e che il legame simbolico con Gerusalemme rimase fortissimo. Ma non è vero che da allora gli ebrei abbiano coltivato, in senso politico, un progetto di “ritorno in massa” alla Terra d’Israele.
La tradizione rabbinica, codificata nel Talmud, anzi, lo vieta. Nel trattato Ketubot 111a, i maestri parlano dei Tre Giuramenti che Dio avrebbe imposto al popolo ebraico dopo l’esilio: il divieto di salire “come un muro”, cioè in massa, verso la Terra d’Israele; il divieto di ribellarsi alle nazioni; e, in parallelo, l’impegno imposto alle nazioni stesse di non opprimere eccessivamente Israele.
Questi giuramenti vennero interpretati come un chiaro divieto religioso di forzare la fine dell’esilio e di ricostituire con mezzi umani, e tanto meno militari, uno Stato ebraico prima dell’avvento del Messia. In altre parole, l’esilio non era una condizione da spezzare con iniziative politiche, ma una fase provvidenziale della storia, da accettare fino alla redenzione escatologica.
Proprio per questo, l’idea moderna di ritorno, inteso come insediamento collettivo e politico, è una creazione ottocentesca del sionismo, nata nell’alveo dei nazionalismi europei. I fondatori del movimento sionista, da Herzl in poi, trasformarono un simbolo religioso in un progetto politico e territoriale, rompendo con secoli di interpretazione rabbinica.
Non a caso, ancora oggi importanti correnti dell’ebraismo ortodosso considerano illegittimo lo Stato di Israele. Il rabbino Yoel Teitelbaum, guida della dinastia chassidica Satmar, scrisse nel 1961 l’opera Vayoel Moshe, in cui ribadiva che la fondazione dello Stato ebraico prima del Messia rappresentava una violazione dei Tre Giuramenti e un peccato grave. Secondo Teitelbaum, lo Stato di Israele non solo non aveva base teologica, ma era causa di nuove sciagure per gli ebrei.
Sulla stessa linea si collocano i gruppi ultraortodossi Neturei Karta, che ancora oggi partecipano a manifestazioni internazionali accanto a Palestinesi e attivisti filopalestinesi, sventolando cartelli con scritto “Judaism rejects Zionism” o “We are Jews, not Zionists”. Essi distinguono nettamente tra il giudaismo quale religione e il sionismo, che considerano un’ideologia politica moderna incompatibile con la Torah. Per questi gruppi, il vero “ritorno a Sion” non può essere opera di governi e di eserciti, ma avverrà soltanto con la venuta del Messia.
Presentare dunque la vicenda come una linea retta che va dall’antichità al 1948, come fa Giuliani, significa semplificare e deformare la realtà storica. La storia della diaspora è stata una storia di adattamenti, integrazioni e convivenze in molte parti del mondo: dalla Spagna medievale allo Yemen, dalla Polonia al Marocco. L’idea di un ritorno politico e collettivo non apparteneva alla tradizione ebraica fino all’Ottocento: è il sionismo che, appropriandosi di simboli religiosi, li ha trasformati in un progetto politico e territoriale.
L’espulsione dopo il 70-135 d.C.
Giuliani parla di «repressione, espulsioni di massa e messa al bando degli ebrei da Gerusalemme, ormai distrutta» come causa della diaspora.
Questa immagine, molto diffusa nella storiografia tradizionale, è oggi messa in discussione. Non vi fu infatti un’espulsione totale del popolo ebraico dalla Palestina. Dopo la distruzione del Secondo Tempio nel 70 e la rivolta di Bar Kokhba nel 135, è vero che gli ebrei furono esclusi da Gerusalemme – ridenominata Aelia Capitolina dall’imperatore Adriano – ma numerose comunità continuarono a vivere in Galilea, in Giudea e nelle aree rurali. Fonti rabbiniche attestano la fioritura di centri di studio come Tiberiade, Sefforis e Cesarea.
La diaspora, dunque, fu un processo graduale, non una deportazione totale. Una parte consistente della popolazione rimase sul posto e, con il passare dei secoli, si convertì prima al cristianesimo bizantino, poi all’Islam dopo la conquista araba del VII secolo. Questo porta a una conseguenza di grande rilievo: i Palestinesi contemporanei non sono “estranei” alla storia antica della regione, ma potrebbero esserne, in parte, i discendenti diretti.
Non si tratta di un’ipotesi ideologica, ma di un’idea riconosciuta anche da importanti guide sioniste. Già nel 1918, David Ben Gurion e Itzhak Ben-Zvi pubblicarono in yiddish un libretto intitolato Eretz Israel in the Past and Present, dove sostenevano che i fellahin palestinesi erano in larga parte i discendenti degli ebrei rimasti nella terra dopo l’epoca romana e gradualmente convertitisi. Scrivevano:
“Gli arabi delle campagne non sono altri che i resti degli antichi abitanti ebraici della terra, che nel corso dei secoli si convertirono all’Islam.”
Ben-Zvi tornò su questo tema negli anni Trenta e Quaranta. Nel suo libro Sha‘ar ha-Yishuv (La porta dell’insediamento ebraico), pubblicato nel 1929 e poi più volte ristampato, ribadiva che la popolazione rurale palestinese conservava “tracce linguistiche, culturali e perfino fisiche” di un’origine ebraica. Egli citava in particolare i villaggi delle montagne di Hebron come comunità che potevano essere considerate eredi dirette degli ebrei antichi.
Anche lo storico ebreo Yitzhak Baer sottolineava che, nel corso dei secoli, “le popolazioni ebraiche non scomparvero mai del tutto dalla Palestina, ma si fusero con i nuovi arrivati, lasciando tracce di continuità”.
Questa consapevolezza era presente nel sionismo delle origini: alcuni pionieri vedevano nei contadini Palestinesi una sorta di “fratelli perduti”, da riportare alla consapevolezza ebraica. In seguito, però, la narrativa ufficiale del movimento sionista cambiò radicalmente, preferendo insistere sulla rottura storica e sull’idea che gli arabi fossero “immigrati” relativamente recenti, al fine di rafforzare la legittimità esclusiva della colonizzazione ebraica.
Ridurre dunque la diaspora a una “espulsione totale e assoluta”, come fa Giuliani, non è solo storicamente scorretto: è anche funzionale a negare la continuità storica della popolazione locale. Se si ammette, come fecero Ben Gurion e Ben-Zvi, che i Palestinesi sono in larga parte discendenti degli ebrei rimasti sul posto, diventa difficile sostenere che essi siano un corpo estraneo, privo di radici storiche in Palestina.
Gli arabi come “immigrati recenti”
Giuliani sostiene: «In questo periodo [ottomano] ci fu una cospicua immigrazione di popolazioni arabe e/o arabizzate, che si sovrapposero a quelle preesistenti».
Questa affermazione riprende una tesi diffusa in certa letteratura filosionista, secondo la quale i Palestinesi sarebbero per lo più frutto di ondate migratorie recenti e dunque privi di un radicamento storico in Palestina. Si tratta però di una semplificazione che non trova riscontro nelle fonti storiche.
È vero che sotto l’Impero Ottomano, come in ogni contesto imperiale, vi furono movimenti di popolazione: drusi provenienti dal Libano, circassi fuggiti dal Caucaso, armeni sopravvissuti ai massacri turchi, e anche arabi attratti dalle opportunità economiche. Tuttavia, la grande maggioranza della popolazione della Palestina ottomana era costituita da contadini arabi, i fellahin, radicati da secoli nella stessa terra. L’“immigrazione” ottocentesca fu dunque un fenomeno marginale rispetto alla continuità di fondo.
La narrativa di una Palestina “svuotata” e poi “ripopolata” è funzionale al mito sionista della terra senza popolo per un popolo senza terra. In realtà, i censimenti ottomani e le fonti di viaggio europee dell’Ottocento descrivono una regione abitata, coltivata, punteggiata di villaggi. Lo stesso rabbino Yehiel Michel Pines, inviato a Gerusalemme nel 1878 dalla Hovevei Zion (Associazione degli Amanti di Sion), scriveva che “la terra è abitata da numerosi arabi, e non vi è un luogo libero che possa accogliere colonie senza acquistare terreni già occupati”.
Se si accetta inoltre l’argomentazione — già ricordata in precedenza — riconosciuta dagli stessi capi sionisti David Ben Gurion e Itzhak Ben-Zvi negli anni ’20 e ’30, secondo cui i fellahin palestinesi erano in gran parte i discendenti degli ebrei antichi rimasti sul posto e convertitisi nel tempo, allora la contrapposizione tra “ebrei autoctoni” ed “arabi immigrati” crolla del tutto. In quella prospettiva, i Palestinesi non appaiono come un corpo estraneo sopraggiunto all’ultimo momento, ma come la continuità vivente della popolazione storica della Palestina.
Negare questo radicamento significa costruire un racconto funzionale a giustificare l’idea che gli arabi non avessero “diritti storici” sulla terra. Ma le ricerche storiche, archeologiche e persino genetiche oggi mostrano un quadro diverso: un tessuto demografico che, pur cambiando religione e lingua nei secoli, mantiene forti elementi di continuità con le popolazioni antiche della regione.
Perciò l’immagine proposta da Giuliani, di una “sovrapposizione recente” che quasi rende i Palestinesi degli ospiti tardivi, non solo è scorretta sul piano storico, ma contribuisce a perpetuare una visione ideologica che nega la legittimità di una presenza radicata e plurisecolare.
La Dichiarazione Balfour
Giuliani scrive: «Iniziava così la collaborazione del Regno Unito con il movimento sionista, creando i presupposti per la formazione di un’entità pre-statuale ebraica in Palestina. In sostanza, diede legittimità alla migrazione di ebrei in quelle terre».
Questa interpretazione trascura aspetti fondamentali. La Dichiarazione Balfour del 2 novembre 1917, indirizzata dal ministro degli Esteri britannico Arthur James Balfour a Lord Rothschild, capo della comunità ebraica britannica, non aveva alcun valore giuridico. Nel 1917 la Palestina faceva ancora parte dell’Impero Ottomano, e la Gran Bretagna non aveva alcuna sovranità su quei territori. Si trattò di una promessa unilaterale, formulata in un contesto coloniale, funzionale agli interessi britannici nella spartizione dell’Impero Ottomano dopo la guerra.
La dichiarazione va letta insieme agli altri accordi paralleli: l’accordo Sykes-Picot del 1916, che prevedeva la divisione del Medio Oriente tra Francia e Gran Bretagna, e le lettere Hussein-McMahon del 1915-16, in cui Londra prometteva agli arabi l’indipendenza se si fossero ribellati contro i turchi. In altre parole, i britannici promisero la stessa terra a più interlocutori, generando contraddizioni destinate a esplodere.
Il testo recitava che il governo britannico «vede con favore la costituzione in Palestina di un focolare nazionale per il popolo ebraico, essendo chiaramente inteso che nulla sarà fatto che possa pregiudicare i diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche esistenti in Palestina». L’ambiguità era evidente: da un lato, l’espressione “focolare nazionale” (national home) non equivaleva a “Stato”, dall’altro, i diritti riconosciuti alle comunità non ebraiche erano soltanto civili e religiosi, non politici. In pratica, la Dichiarazione concedeva diritti politici a una minoranza ebraica internazionale, ma negava la legittimità politica della maggioranza araba, che costituiva circa il 90% della popolazione.
Non sorprende, quindi, che la Dichiarazione suscitasse fin da subito un’opposizione durissima tra i capi arabi e palestinesi, che la percepirono come un tradimento delle promesse di indipendenza e come un atto di espropriazione politica. Già al Congresso Arabo di Damasco del 1919, i delegati provenienti dalla Siria storica (che comprendeva allora anche la Palestina) dichiararono inaccettabile la Dichiarazione Balfour, affermando che la Palestina era parte integrante della grande Nazione araba e che la volontà della sua popolazione non poteva essere ignorata.
Le tensioni esplosero presto sul terreno. Nel 1920, durante le celebrazioni della Nabi Musa a Gerusalemme, manifestazioni arabe si trasformarono in scontri violenti contro la comunità ebraica, con decine di morti e feriti. Quelle rivolte furono la prima espressione di una resistenza popolare contro l’applicazione pratica della Dichiarazione Balfour, che i Palestinesi percepivano come l’inizio di un processo di colonizzazione sostenuto dall’amministrazione britannica.
Il passaggio da promessa a strumento legale avvenne pochi anni dopo: nel 1922, con il Mandato britannico sulla Palestina, la Dichiarazione Balfour fu incorporata integralmente nel testo approvato dalla Società delle Nazioni. Un atto che in origine non aveva alcun valore giuridico divenne così parte del diritto internazionale, istituzionalizzando il sostegno al progetto sionista e relegando la popolazione araba in una condizione subalterna.
Parlare dunque di una Dichiarazione che “diede legittimità alla migrazione ebraica” significa travisare la sua natura. Più che legittimità, essa rappresentò un atto di imperialismo coloniale: una potenza europea prometteva a un movimento politico internazionale una terra abitata da un altro popolo, senza che quest’ultimo fosse minimamente consultato.
Il Piano di Partizione ONU del 1947
Giuliani sostiene: «L’élite palestinese e la Lega Araba rifiutarono la deliberazione e risposero con una guerra d’aggressione contro Israele».
Questa formulazione è fuorviante perché decontestualizza il rifiuto palestinese e arabo, presentandolo come una scelta irrazionale o dettata da odio ideologico. In realtà, la Risoluzione 181 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, approvata il 29 novembre 1947, prevedeva la divisione della Palestina mandataria in due Stati, uno ebraico e uno arabo, con Gerusalemme posta sotto amministrazione internazionale. Ma la ripartizione era profondamente squilibrata: il 56% del territorio sarebbe andato allo Stato ebraico, sebbene gli ebrei rappresentassero circa un terzo della popolazione e fossero proprietari, secondo i dati ufficiali britannici del 1945, di appena il 6-7% delle terre.
Non era soltanto una questione di proporzioni, ma di qualità del territorio. Allo Stato ebraico venivano assegnate aree strategiche e fertili: la pianura costiera, la Jezreel Valley, parte della Galilea, cioè le zone migliori per agricoltura e infrastrutture. Allo Stato arabo, invece, sarebbero rimasti territori frammentati, meno fertili e privi di continuità geografica. In pratica, la popolazione araba, che costituiva la maggioranza assoluta, vedeva riconosciuta una sovranità debole su un mosaico di aree residuali.
Non sorprende dunque che i Palestinesi percepissero la proposta come radicalmente iniqua. Parlare semplicemente di “rifiuto” oscura il fatto che la maggioranza araba fu privata del diritto all’autodeterminazione su una terra in cui costituiva la parte prevalente della popolazione. Per molti Palestinesi, la Risoluzione 181 rappresentava non una soluzione di compromesso, ma una forma di espropriazione politica, sancita dalle potenze internazionali.
C’è poi un altro elemento spesso dimenticato: lo stesso UNSCOP (Comitato Speciale delle Nazioni Unite sulla Palestina), incaricato di elaborare una proposta, aveva discusso due opzioni. Oltre al piano di partizione, approvato dalla maggioranza dei membri, vi era una proposta di minoranza che prevedeva la creazione di uno Stato federale unico, con ampie autonomie per le due comunità, capitale condivisa a Gerusalemme e immigrazione ebraica regolata in modo da non alterare drasticamente l’equilibrio demografico. Era un modello più inclusivo, che cercava di tenere conto tanto delle aspirazioni ebraiche quanto di quelle arabe.
Questa soluzione fu però respinta dal movimento sionista, che non era disposto ad accettare una sovranità condivisa o una realtà binazionale. Per i dirigenti sionisti, l’obiettivo centrale era la creazione di uno Stato ebraico indipendente con una maggioranza demografica ebraica: un compromesso federale non avrebbe soddisfatto tale condizione.
Alla luce di questi elementi, il rifiuto arabo del piano ONU non appare come un atto di “aggressione gratuita”, ma come la reazione a una proposta percepita come profondamente ingiusta, imposta dall’esterno e favorevole a una minoranza appena insediata in larga parte attraverso l’immigrazione recente. In questo contesto esplose la guerra del 1947-48: per gli israeliani fu la “guerra d’indipendenza”, per i Palestinesi la Nakba, la “catastrofe”, segnata dall’espulsione di circa 700.000 persone dalle loro case.
Ridurre tutto a un rifiuto “irrazionale” e a una “guerra di aggressione” significa cancellare la complessità del momento storico e negare la legittimità delle rivendicazioni Palestinesi, che chiedevano semplicemente ciò che in quegli anni veniva riconosciuto ad altri popoli colonizzati: il diritto all’autodeterminazione e alla sovranità sul proprio territorio.
Le guerre successive
Giuliani scrive: «Seguirono altre guerre d’aggressione, intifade e attentati contro lo Stato ebraico».
Questa formulazione, estremamente generica, appiattisce vicende storiche tra loro molto diverse e, soprattutto, cancella le responsabilità israeliane, presentando il conflitto come una sequenza di attacchi unilaterali subiti da Israele.
La guerra del 1948, ad esempio, non fu semplicemente una “guerra di aggressione”. Per Israele rappresentò la nascita dello Stato ebraico, ma per i Palestinesi fu la Nakba, la “catastrofe”: circa 700.000 persone furono espulse o costrette a fuggire dalle proprie case, e a tutt’oggi a loro e ai loro discendenti viene negato il diritto al ritorno. Parlare solo di aggressione araba significa ignorare l’espulsione sistematica di popolazioni civili e la distruzione di centinaia di villaggi Palestinesi.
Analogamente, dire che nel 1967 gli Stati arabi volessero distruggere Israele è semplicemente falso. La Guerra dei Sei Giorni non può essere interpretata come un tentativo arabo di annientare lo Stato ebraico. Lo stesso Moshe Dayan, ministro della Difesa israeliano all’epoca, ammise anni dopo che buona parte delle tensioni con la Siria non erano frutto di una strategia aggressiva di Damasco, bensì di provocazioni deliberate da parte israeliana. In un’intervista confidenziale concessa al giornalista Rami Tal nel 1976, resa pubblica solo nel 1997, Dayan raccontò che circa l’80% degli scontri lungo il confine con la Siria erano stati “iniziati intenzionalmente da Israele”. L’esercito, spiegò, era solito inviare trattori a lavorare nelle zone demilitarizzate, sapendo che i siriani avrebbero reagito. Se i siriani non sparavano subito, i trattori venivano spinti ancora più avanti fino a provocare il fuoco siriano. A quel punto Israele replicava con artiglieria e aviazione, presentando la reazione siriana come un atto di aggressione.
Dayan stesso definì questa pratica un espediente calcolato, volto a creare il casus belli che permettesse a Israele di intervenire con la legittimità apparente di chi “si difende”. È in questo contesto che maturò la Guerra dei Sei Giorni, la quale, lungi dall’essere una reazione a un pericolo esistenziale, fu il risultato di una scelta politica precisa: cogliere l’occasione per conquistare territori strategici. In sei giorni Israele occupò Gaza, la Cisgiordania, Gerusalemme Est, il Sinai e le Alture del Golan. Quell’espansione militare modificò per sempre la geografia del conflitto e pose le basi per l’attuale situazione di occupazione e colonizzazione, che Israele non ha mai davvero interrotto.
In questo quadro, la decisione di Nasser di chiudere lo Stretto di Tiran non fu l’inizio di un piano di sterminio, ma la reazione a un’escalation di pressioni e provocazioni israeliane. Una mossa forse azzardata, ma che rispondeva a una dinamica di tensioni già alimentate da Israele lungo i confini settentrionali.
La guerra del 1973, nota come Guerra del Kippur, è un altro esempio di come la formula “aggressione araba” semplifichi la realtà. Egitto e Siria attaccarono non per distruggere Israele, ma per riconquistare i territori persi nel 1967. Fu un conflitto drammatico, ma non un tentativo di cancellare lo Stato ebraico dalle carte geografiche, come spesso viene narrato.
Parlare genericamente di “guerre di aggressione” significa dunque oscurare la complessità di questi conflitti e deresponsabilizzare Israele, che non fu un attore passivo vittima degli eventi, ma al contrario prese decisioni politiche e militari precise, spesso orientate a consolidare e ampliare il proprio controllo territoriale.
Gli Accordi di pace
Giuliani conclude affermando: «nonostante vari tentativi di pervenire ad accordi (Oslo 1 e 2, accordi di Abramo), tutti disattesi, in particolare da parte palestinese».
Questa è una lettura che rovescia la realtà, perché riduce la complessità dei negoziati a una presunta incapacità palestinese di rispettare gli impegni, ignorando ciò che accadeva sul terreno.
Gli Accordi di Oslo, firmati nel 1993-95, furono accolti come una svolta storica, ma mentre a Washington si celebrava la “pace”, nei Territori Occupati Israele continuava ad espandere gli insediamenti. Nel 1993 i coloni in Cisgiordania e Gaza erano circa 110.000; tre anni dopo, alla fine della stagione di Oslo, erano già saliti a 150.000. Questo dato da solo rivela la contraddizione: si negoziava il futuro di uno Stato palestinese mentre, parallelamente, si consolidava sul terreno una realtà che lo rendeva sempre più impraticabile.
Yitzhak Rabin, l’uomo che firmò Oslo e che spesso viene ricordato come “il premier della pace”, fu esplicito nei suoi discorsi: ai Palestinesi, disse, sarebbe stato concesso “qualcosa di meno di uno Stato”. Non sovranità piena, non controllo delle frontiere, non diritto al ritorno dei rifugiati, ma un’entità ridotta, sottoposta al controllo militare ed economico israeliano. Nei suoi ultimi interventi in Knesset, prima di essere assassinato, Rabin parlò di una “autonomia estesa” e non di uno Stato sovrano: le parole, oggi, pesano quanto i fatti.
La stessa logica riemerse a Camp David nel 2000, quando Ehud Barak propose ai Palestinesi un “pacchetto generoso” che però, nei dettagli, configurava un arcipelago di cantoni separati, privi di continuità territoriale, con Israele a mantenere il controllo delle frontiere, dello spazio aereo e delle risorse idriche. Non stupisce che i Palestinesi lo respinsero: non era la nascita di uno Stato, ma la formalizzazione di un sistema di dipendenza. Anche il piano Olmert del 2008, pur più ampio nelle concessioni, manteneva questa asimmetria: in cambio del riconoscimento delle colonie israeliane nelle aree più fertili e strategiche della Cisgiordania, ai Palestinesi venivano offerte porzioni di deserto nel Negev.
Negli anni successivi, la maschera è caduta del tutto. Benjamin Netanyahu ha dichiarato più volte, senza ambiguità, che non permetterà mai la nascita di uno Stato palestinese. A fronte di queste posizioni, imputare il fallimento dei negoziati ai Palestinesi non è solo parziale: significa occultare il dato strutturale, ovvero che Israele ha usato i processi di pace non per porre fine all’occupazione, ma per gestirla in modo più accettabile agli occhi della comunità internazionale.
Gli Accordi di Abramo del 2020, infine, hanno confermato questa logica: normalizzazione dei rapporti tra Israele e vari Paesi arabi senza che la questione palestinese fosse risolta. Di fatto, i Palestinesi sono stati esclusi dal tavolo, trasformati in una variabile secondaria nel gioco geopolitico regionale.
Ascrivere, come fa Giuliani, la colpa del fallimento degli accordi di pace ai Palestinesi significa non vedere ciò che è evidente: la soluzione del conflitto non è mai stata praticabile perché Israele ha continuato ad agire come potenza occupante, consolidando una realtà in cui lo Stato palestinese non è mai stato una prospettiva concreta, ma soltanto una finzione utile a guadagnare tempo e legittimità internazionale.
Conclusione
Il testo di Giuliani, pur nelle sue intenzioni divulgative, non restituisce la complessità della questione israelo-palestinese. Le sue pagine tendono a proporre come verità consolidate affermazioni che la ricerca storica oggi considera controverse, tralasciano elementi fondamentali della narrazione palestinese e finiscono per attribuire unilateralmente le responsabilità del conflitto. Ne deriva una ricostruzione che, anziché chiarire, rischia di alimentare visioni distorte e sbilanciate.
La storia della Palestina non può essere ridotta al solo “ritorno ebraico”. È anche — e inseparabilmente — la storia di una popolazione araba-palestinese radicata da secoli in quelle stesse terre, spesso erede degli stessi ebrei dell’antichità rimasti sul posto e convertitisi nel tempo. È la storia di comunità che hanno visto restringersi progressivamente spazi, risorse e diritti, fino a ritrovarsi sotto occupazione militare e in una condizione di marginalizzazione permanente.
A oltre settantacinque anni dalla nascita di Israele, la questione palestinese resta aperta: milioni di rifugiati vivono ancora in campi senza possibilità di ritorno, la Cisgiordania è frammentata da colonie e check-point, e Gaza è sottoposta a un assedio imposto da Israele dal 2007, dopo la presa del potere da parte di Hamas. Da allora, due milioni di persone vivono intrappolate in una striscia di terra sovraffollata, privata di libertà di movimento, sottoposta a restrizioni su beni di prima necessità, elettricità, acqua potabile e cure mediche. Negli ultimi anni, e in particolare dopo le operazioni militari del 2023-25, la situazione è degenerata in forme di violenza di massa che molti osservatori e organismi per i diritti umani descrivono come un vero e proprio genocidio. Parlare oggi di soluzioni senza tener conto di queste realtà equivale a proporre formule vuote.
Se l’obiettivo è comprendere e non semplificare, allora occorre dare spazio pieno alla voce palestinese, con il peso delle sue perdite, delle espulsioni, delle espropriazioni e delle rivendicazioni di giustizia rimaste inascoltate per decenni. Ignorare questa dimensione significa perpetuare la rimozione di un popolo che continua a vivere sotto occupazione, in esilio o sotto assedio.
Per i Palestinesi, la storia del 1948 non è un capitolo chiuso, ma l’inizio di una Nakba continua (al-Naqba al-mustamirra), una catastrofe che non si è mai interrotta: dall’espulsione dei rifugiati e la confisca delle terre, alla colonizzazione della Cisgiordania, fino all’assedio di Gaza. Ogni generazione ha conosciuto la stessa condizione di privazione e precarietà, come se il trauma fondativo della perdita si rinnovasse senza sosta.
La storia, se affrontata con onestà e rigore, non è mai neutra: essa può diventare uno strumento di denuncia e di responsabilità. Restituire complessità a questa vicenda significa anzitutto riconoscere la condizione palestinese per ciò che è stata ed è tuttora — una catastrofe ininterrotta fatta di espulsioni, ingiustizie e resistenza — e aprire così spazi di possibilità: per la memoria, per la giustizia, per la pace.
Questo articolo è coperto da ©Copyright, per cui ne è vietata la riproduzione parziale o integrale. Per maggiori informazioni sull'informativa in relazione al diritto d'autore del sito visita Questa pagina.