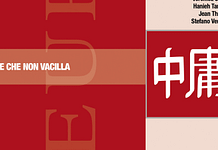Nel corso della visita ufficiale compiuta nel maggio dello scorso anno in Arabia Saudita dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump vi furono due momenti memorabili. Il primo fu quello della danza cerimoniale delle spade, eseguita a Riyâd all’esterno del Qasr al-Murabba. Circondato da alti funzionari sauditi, Trump ondeggiava avanti e indietro visibilmente partecipe e compiaciuto; assieme a lui prendevano parte alla danza il segretario di Stato Rex Tillerson, il ministro del commercio Wilbur Ross, il capo stratega Steve Bannon, il capo di gabinetto della Casa Bianca Reince Priebus e il direttore del Consiglio Economico Nazionale Gary Cohn. La danza delle spade, chiamata in arabo al-‘ardah, è originaria nel Nejd, dove veniva eseguita dagli uomini che si preparavano a partire per la guerra.
Il secondo momento, altrettanto spettacolare, fu quello dell’inaugurazione del Global Center for Combating Extremist Ideology: il presidente statunitense Trump, il re saudita Salmân bin ‘Abd al-‘Azîz Al Sa‘ûd e il presidente egiziano ‘Abd al-‘Fattâh al-Sîsî tenevano le mani su un globo luccicante che illuminava di una luce sinistra l’espressione rapita dei loro volti. La scena scatenò la fantasia degli osservatori e fece pensare ad una seduta spiritica o a qualcosa del genere, tanto che The Church of Satan dovette chiarire sul proprio profilo Twitter che non si era trattato di un rituale satanista.
Questi due eventi intendevano verosimilmente enfatizzare in maniera teatrale il rinnovo di un’alleanza stipulata settantadue anni prima, il 14 febbraio 1945, quando ‘Abd al-‘Azîz ibn Sa‘ûd e Franklin Delano Roosevelt, reduce dalla conferenza di Jalta, si incontrarono a bordo dell’incrociatore USS Quincy (CA-71) nel canale di Suez. In quella circostanza, che inaugurò il processo di sostituzione del patrocinio americano a quello britannico, il presidente statunitense e il monarca wahhabita conclusero un patto che garantiva all’Arabia Saudita la protezione militare americana in cambio dell’accesso al petrolio da parte degli USA. Il patto americano-saudita si articolava in quattro punti: 1) la stabilità dell’Arabia Saudita rientra negli “interessi vitali” degli USA, i quali assicurano la protezione incondizionata alla famiglia regnante ed al Regno; 2) negli “interessi vitali” statunitensi rientrano la stabilità di tutta quanta la Penisola e l’egemonia regionale dell’Arabia Saudita; 3) il Regno saudita assicura agli USA l’essenziale dell’approvvigionamento energetico, per cui è garantito all’Aramco il monopolio dello sfruttamento di tutti i giacimenti petroliferi del Regno stesso per almeno sessant’anni; 4) tra gli USA e l’Arabia Saudita viene stabilito un partenariato economico, commerciale e finanziario.
Nel 2005, all’epoca della presidenza di George W. Bush, questi accordi furono rinnovati per altri settant’anni; ma, trascorso un quinquennio, i rapporti del regime saudita con gli USA subirono un certo raffreddamento a causa della renitenza statunitense ad intervenire direttamente in prima persona contro lo Stato siriano ed a causa degli accordi sul nucleare iraniano.
In seguito all’elezione di Donald Trump, che ha sempre manifestato la sua netta riprovazione nei confronti dell’accordo sul nucleare iraniano, il vecchio patto stipulato a bordo della Quincy ha ripreso vigore: l’alleanza tra Washington e Riyâd si è rinsaldata nell’impegno comune contro l’influenza esercitata dalla Repubblica Islamica dell’Iran e contro le posizioni tenute dagli alleati di quest’ultima. L’Arabia Saudita si è infatti impegnata su vari fronti, in maniera diretta o indiretta, contro gli alleati di Teheran, e ciò a partire dalla Siria, dove Riyâd ha sostenuto con armi e denaro i “ribelli moderati” e le bande terroriste.
In seguito, nel marzo 2015, una coalizione a guida saudita ha attaccato militarmente lo Yemen provocando più di 13.000 vittime tra la popolazione civile ed ha imposto un blocco ai porti ed agli aeroporti del Paese. L’aggressione, il cui obiettivo consisteva nel rimettere al potere il fantoccio ‘Abdrabbuh Mansûr Hâdî per restaurare l’egemonia saudita nel Paese, si è risolta però in un disastro per la petromonarchia: la resistenza yemenita, guidata dal movimento Ansârullâh, ha distrutto una quarantina di aerei della coalizione, più di 1200 tra carri armati e veicoli corazzati e una decina di navi da guerra.
Sul fronte libanese, al fine di indebolire Hezbollâh e destabilizzare il Paese dei Cedri, Riyâd ha spinto alle dimissioni il primo ministro Sa‘d Harîrî, personalmente indebitato per circa 4 miliardi di dollari col governo saudita. Il 4 novembre 2017, parlando in diretta dalla capitale del Regno wahhabita sul canale televisivo Al-‘Arabiyya, il primo ministro libanese, affiancato dal principe ereditario Muhammad bin Salmân, sferrò un violento attacco contro l’Iran. “Dovunque è presente, – dichiarò Harîrî – l’Iran semina divisione e distruzione. La prova è la sua interferenza nei Paesi arabi, per non parlare del suo profondo risentimento verso la nazione araba (…) Hezbollâh è il suo braccio armato non solo in Libano, ma anche in altri Paesi arabi (…) Purtroppo ho capito che i miei connazionali seguono l’Iran nel tentativo di far uscire il Libano dall’ambito arabo. Glorioso popolo del Libano, Hezbollâh è riuscito, grazie alle armi, ad imporre una situazione di fatto (…) Voglio dire all’Iran ed ai suoi accoliti che saranno sconfitti”. Al termine del suo discorso, Sa‘d Harîrî telefonò al presidente libanese Michel Aoun per annunciargli ufficialmente le proprie dimissioni.
Nello storico incontro avvenuto bordo della Quincy, Roosevelt aveva chiesto a ‘Abd al-‘Azîz ibn Sa‘ûd di appoggiare il progetto sionista della creazione di un “focolare nazionale ebraico” in Palestina, ma aveva ottenuto un rifiuto formale. Oggi, sotto l’alto patronato della presidenza Trump, il regime wahhabita e quello sionista sono coalizzati in un’alleanza de facto contro la Repubblica Islamica dell’Iran. In questa situazione, gravida di drammatici sviluppi, il 6 dicembre 2017 il presidente statunitense ha gettato altra benzina sul fuoco, annunciando la propria decisione di riconoscere ufficialmente Gerusalemme come capitale dello Stato ebraico e demandando al Dipartimento di Stato il trasferimento dell’ambasciata degli USA da Tel Aviv a Gerusalemme (trasferimento che, stando a successive dichiarazioni di Trump e del segretario di Stato Tillerson, dovrebbe avvenire nel giro di un paio d’anni).
Ciò ha dato modo al presidente Recep Tayyip Erdoğan di riproporre il ruolo di guida della Turchia nel mondo musulmano convocando a Istanbul i rappresentanti dei cinquantasette Paesi della Conferenza Islamica. “Siamo qui – ha esordito il ministro degli Esteri turco Mevlüt Çavuşoğlu – per promuovere il riconoscimento di Gerusalemme Est come capitale della Palestina da parte della comunità internazionale e la formazione di uno Stato palestinese entro i confini stabiliti nel 1967”. A sua volta Erdoğan ha dichiarato in relazione all’annuncio statunitense: “Una decisione del genere riguarda una città già sotto occupazione, per cui non è valida. Si tratta di una decisione con cui l’America vuole legittimare l’occupazione israeliana”. Quindi ha accusato gli Stati Uniti di provocare un incendio che “brucerà tutta la regione e il mondo”. Al termine della riunione, i rappresentanti dei Paesi della Conferenza Islamica hanno diffuso un comunicato in cui Gerusalemme Est viene proclamata capitale dello Stato di Palestina e gli altri Paesi vengono invitati a riconoscerne la legittimità.
Intanto il generale Qâsem Soleimânî, capo della Brigata Gerusalemme (Niru-ye Qods) ha assicurato ai capi militari del Movimento Islamico di Resistenza (Harakat al-Muqâwama al-Islâmiyya) e del Movimento per il Jihâd Islamico in Palestina (Harakat al-Jihâd al-Islâmî fî Filastîn) la disponibilità dell’Iran a fornire alle forze della Resistenza islamica palestinese ogni aiuto necessario per difendere la Moschea di Al-Aqsâ. Il generale iraniano ha dichiarato che altre forze della Resistenza nella regione sono pronte a combattere per la difesa della Moschea, che i sionisti progettano di distruggere per costruire al suo posto il “Terzo Tempio” giudaico[1]. Da parte sua Khâled Mesh‘al, ex presidente dell’ufficio politico di Hamâs, ha affermato che l’organizzazione ha profondi rapporti con l’Iran e con Hezbollâh. “Le nostre relazioni con l’Iran si sono ampliate e facciamo parte dello stesso Asse della Resistenza”, ha dichiarato; quindi, esprimendo gratitudine per il sostegno dell’Iran, ha detto che le relazioni di Hamâs con la Repubblica Islamica non sono mai state interrotte, anche se hanno conosciuto alcuni alti e bassi.
Più che i comunicati della Conferenza Islamica, a preoccupare gli Stati Uniti e l’entità sionista è la Repubblica Islamica dell’Iran. Nella prima metà di dicembre, funzionari della Difesa americani e israeliani hanno elaborato, in un incontro alla Casa Bianca, un programma strategico congiunto avente lo scopo di “contenere” l’Iran. Il documento di reciproca intesa firmato dalle due delegazioni, guidate rispettivamente dai consiglieri alla sicurezza nazionale Herbert McMaster e Meir Ben-Shabbat, prevede l’istituzione di quattro gruppi di lavoro incaricati di impedire l’attuazione del programma nucleare e balistico iraniano e di ostacolare la consegna di armamenti agli alleati dell’Iran nella regione.
Un altro terreno di scontro fra gli USA e l’Iran è il Kurdistan, che, per effetto degli accordi Sykes-Picot del 1916, si trova diviso fra Turchia, Siria, Iraq ed Iran. Gli Stati Uniti hanno deciso di schierare, sul confine che separa la Turchia dall’Iraq e lungo il corso dell’Eufrate in Siria, una forza di sicurezza transfrontaliera di 30.000 uomini che coordinerà le sue attività coi combattenti curdi delle Forze Democratiche Siriane (FDS) e delle Unità di Protezione del Popolo Curdo (YPG), emanazione dell’organizzazione terroristica del PKK. Il 17 gennaio 2018 il segretario di Stato Rex Tillerson ha dichiarato che la presenza militare statunitense nel Kurdistan siriano (attualmente costituita da 5000 soldati e altrettanti mercenari) ha lo scopo di impedire la ricomparsa del Daesh (il cosiddetto “Stato Islamico”), ma soprattutto di “contribuire a creare una situazione di sufficiente stabilità” affinché i Siriani possano scacciare Bashâr al-Asad e porre fine all’influenza iraniana. “Se gli Stati Uniti si disinteressassero della Siria – ha detto Tillerson – darebbero all’Iran la possibilità di rafforzare la loro posizione”. Ed ha aggiunto: “L’Iran persegue il dominio del Medio Oriente e la distruzione del nostro alleato israeliano”.
L’iniziativa statunitense, come ha osservato l’analista Kamal Louadj, mira a “creare una zona tampone completamente instabile tra la Siria, la Turchia, l’Iraq e l’Iran, per spezzare l’alleanza che ha sconfitto il Daesh. Infatti, installandosi durevolmente nel Kurdistan, gli Stati Uniti taglierebbero il cordone ombelicale che lega l’Esercito Arabo Siriano e le milizie sciite irachene Al-Hashd al-Sha‘bî, le due forze che con l’appoggio dell’aviazione russa hanno ripulito la zona frontaliera tra i loro due rispettivi Paesi. Questo, da un lato; dall’altro, si tratta di neutralizzare la Turchia, creando gravi problemi alla sua frontiera con la Siria. Questa frattura consentirebbe di tagliare l’asse che va dall’Iran alla Siria”[2].
A quanto pare, le spade che Tillerson e Trump hanno impugnate danzando a Riyâd non verranno rinfoderate tanto presto.
NOTE
[1] Cfr. Richard Ostling, La ricostruzione del Tempio di Gerusalemme, “Eurasia”, a. XI, n. 4, Ott. – Dic. 2014, pp. 129-131.
[2] Kamal Louadj, Présence militaire au Kurdistan, cheval de Troie US dans la région?, sputniknews.com, 18 gennaio 2018.
Questo articolo è coperto da ©Copyright, per cui ne è vietata la riproduzione parziale o integrale. Per maggiori informazioni sull'informativa in relazione al diritto d'autore del sito visita Questa pagina.