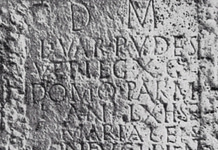Il terzo grande ponte sul Bosforo – dopo il Boğazıcı Kőprűsű del 1973 e il Fatih Sultan Kőprűsű del 1988 – sarà costruito dall’italiana Astaldi in collaborazione con la turca Içtaş.
Un esempio di grande investimento strutturale reso possibile dall’intervento pubblico libero dal cappio usuraio del “debito pubblico” (fra l’altro passato in Turchia dal 110 % del 2001 al 45 % del 2009).
In Italia, come mostra la ricerca del CENSIS “Tornare a desiderare le infrastrutture” (marzo 2012), il periodo nero per le grandi opere è iniziato con gli anni Novanta del secolo scorso, in corrispondenza delle prime revisioni di spesa e dello smantellamento dello Stato sociale nel nome della globalizzazione e della “libertà dei mercati”: la mancanza di fondi pubblici da destinare a un’effettiva crescita produttiva si specchia nel progressivo ritirarsi dello Stato dalla scena economica.
Registriamo nella ricerca del CENSIS le seguenti considerazioni:
(p.9) “Quel 1992 è l’anno in cui è suonato anche l’allarme per i conti dello Stato e l’indebitamento pubblico ha superato il 100% del Pil. Inoltre, le politiche basate sul deficit spending subiscono il primo arresto significativo. Da quel momento la spesa pubblica è stata soggetta a una continua revisione per il suo contenimento e parallelamente si è andata esasperando la competizione per catturare risorse finanziarie pubbliche”
(p. 17) “In effetti, nella prima metà degli anni ’90 la componente in conto capitale è stata duramente penalizzata per una politica di bilancio orientata al rispetto degli impegni comunitari. Una problematica che si è riproposta a partire dal 2009, complici i primi decreti ‘anticrisi’ e che sembra amplificarsi negli attuali scenari di debolezza dei bilanci pubblici”.
Indipendentemente dal giudizio sulle singole scelte infrastrutturali (da valutare e non necessariamente sempre condivisibili, ovviamente), il quadro generale risulta veramente negativo, contraddistinto da un blocco diventato fisiologico in un organismo sclerotizzato: e il lavoro italiano prende la strada del Bosforo, senza che la politica “occidentale” abbia neppure tracciato i lineamenti di una comunità di intesa fra Italia/Europa e Turchia.
Questo articolo è coperto da ©Copyright, per cui ne è vietata la riproduzione parziale o integrale. Per maggiori informazioni sull'informativa in relazione al diritto d'autore del sito visita Questa pagina.